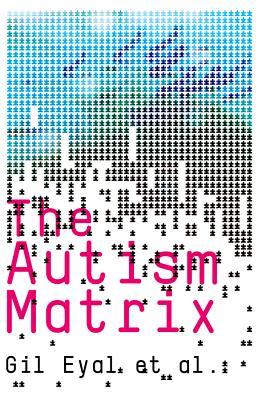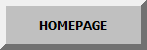AT BIBLIOTECA 3
























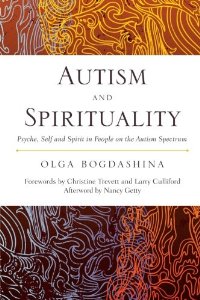
Autism and Spirituality (Jessica Kingsley Publishers 2013) è un libro singolare, e per me abbastanza inquietante. Olga Bogdashina qui lascia il territorio della scienza per inoltrarsi in quello sconfinato e nebuloso della spiritualità, senza tuttavia avere alle spalle un solido percorso filosofico o filosofico-religioso, e finendo quindi su terreni scivolosi, nei quali il conflitto delle opinioni è forte, e in cui molte sono le strade, e molti gli sguardi possibili. Privo di una fondazione critica dei concetti di religione e spiritualità, ed evidentemente incline a considerare la religione come un fenomeno che scaturisce soltanto dall’interiorità del singolo, esattamente come la spiritualità, ma in un secondo momento (la spiritualità avrebbe priorità cronologica e logica – p. 35), il testo basa la sua argomentazione sulle esperienze raccontate da persone con autismo ad altissimo funzionamento o asperger, coinvolgendo i soggetti autistici LF averbali mediante induzioni altamente problematiche.
«Mentre l’autismo non è una cultura nel senso antropologico stretto della parola, esso funziona come una cultura in quanto incide sui modi in cui gli individui autistici si comportano, comprendono e comunicano con il mondo. Dato che l’esperienza originale del mondo che hanno i bambini autistici è fondamentalmente sensoriale, il loro linguaggio originale interno (come strumento per formulare ed esprimere il pensiero) consiste di immagini sensoriali-percettive (multidimensionali). Questo ‘linguaggio’ diviene centrale per il loro sviluppo intellettuale ed emozionale (Bogdashina 2004), avvicinandolo alla ‘visione originaria’ (nei termini della concettualizzazione di Robinson – 1983) e così più vicino alla ‘spiritualità come esperienza pre-linguistica / non-linguistica’. I ‘linguaggi autistici’ degli individui autistici non-verbali sono molto differenti dai linguaggi convenzionali verbali e non-verbali: e coloro che sono verbali usano ancora il linguaggio verbale differentemente dai loro partner comunicativi non-autistici. ‘Il linguaggio verbale ha un uso differente per una persona con autistica e per una persona non-autistica’» (O’ Neill 2000). (pp. 49-50)
Questo piccolo brano è indicativo del modo di argomentare della Bogdashina, che procede per continue citazioni di autori disparati (psicologi, ma anche filosofi e persone con autismo ad altissimo funzionamento), con un grado di rigore alquanto tenue. Qui, ad esempio, la sussistenza di qualcosa di simile ad una cultura autistica viene evocato acriticamente. L’uso del termine cultura nell’autismo è estremamente problematico se manca una preliminare definizione minimale della cultura stessa. E a mio avviso la definizione non può che essere questa: un sistema di segni che si trasmette da una generazione all’altra mediante apprendimento. Se ciò cui vogliamo applicare l’etichetta cultura non corrisponde a questa definizione minimale, l’uso del termine deve essere respinto. Ma O.B. afferma che «le persone autistiche si riconoscono fra loro: sembrano essere membri della stessa comunità» (p. 154) e mi conferma nella mia idea che il parlare dell’autismo in generale e senza molti distinguo sia ormai una trappola, un produrre una notte in cui tutte le vacche sono grigie.
Il punto centrale di tutto il discorso di Olga Bogdashina, che le consente di sostenere che le persone con autismo siano più aperte alle esperienze spirituali, è la sua identificazione della spiritualità con una condizione pre-linguistica (e quindi tipica della primissima fase della vita), in cui il soggetto non subisce l’effetto dei filtri culturali, e sperimenterebbe un’assenza di confine tra se stesso e la realtà circostante. E la Bogdashina identifica questa condizione, che ritiene altamente positiva e che si estenderebbe per i primi anni di vita, con quella raggiunta dai mistici o dai maestri spirituali con duro lavoro di perfezionamento. Purtroppo, con la crescita, la cultura in cui l’individuo è immerso lo priva di queste meravigliose possibilità, che invece all’autistico rimangono aperte (fortunato!). «Dalle mie comunicazioni personali con persone nello spettro dell’autismo risulta che la maggioranza di esse avverte che il proprio ‘sé’ non è ristretto al corpo ma non ha alcun confine» (p.130)
O.B. ci mette di tutto, in questa sua argomentazione-minestrone: spiritualità degli animali, esperienze extracorporee di morte-non-morte, telepatia. Manca solo l’incontro con intelligenze aliene, e saremmo a posto. Il tutto comporta, peraltro, una svalutazione del linguaggio, della cultura, e di ciò che è non-autistico, come Olga Bogdashina etichetta quello che appartiene ai cosiddetti neurotipici. Questo libro è paradossale: anche l’uso dei termini autistico e non-autistico, per cui ciò che è non-autistico subisce una privazione, ridefinisce l’umano in un modo del tutto inaccettabile.

Ormai è una verità stabilita: tra i ricoverati negli ospedali psichiatrici (morocomi, frenocomi, manicomi) dei tempi andati, una gran parte era costituita da disabili mentali, che oggi sarebbero inclusi nello spettro dell’autismo. Di questo elemento ogni ricerca che tocchi l’istituzione manicomiale deve tenere conto. Come ex veneziano e come padre di un ragazzo autistico a basso funzionamento sono stato invogliato alla lettura di A sé e agli altri, a cura di C. Russo, Michele Capararo ed Enrico Valtellina (Mimesis 2013). Storia della manicomializzazione dell’autismo e delle altre disabilità relazionali nelle cartelle cliniche di S. Servolo: il sottotitolo del libro è esplicativo, ma anche problematico. Si tratta di un testo complesso, di un tessuto di saggi di vari autori (9, di differente formazione) che hanno al centro la lettura di cartelle cliniche del manicomio di S. Servolo a Venezia, redatte in un ampio arco di anni. Cartelle talvolta ricche di informazioni, più spesso tristemente scarne, quasi vuote, ripetitive, comunicanti un sostanziale disinteresse dell’istituzione e di chi vi operava per l’altro, per il ricoverato, e per la sua sofferenza.
Un piccolo inciso personale. Ai miei ricordi veneziani degli anni Cinquanta e Sessanta appartengono espressioni allora ricorrenti sulla bocca della gente, anche per strada, frequentissime: «El vién fóra da S. Sèrvoło!» (viene fuori da S. Servolo!); «Te mando a S. Sèrvoło!» (ti mando a S. Servolo!) «Fate védar da Fàtovich!» (Fatti vedere da Fattovich!). Quest’ultimo, che diresse il manicomio veneziano maschile di S. Servolo e quello femminile di S. Clemente (siti in due diverse isole della laguna) in qualità di primario dal 1935 al 1969, godeva fama di individuo bizzarro, non meno matto dei matti sui quali usava ampiamente le pratiche della camicia di forza e dell’elettroshock. In quel tempo mio padre era segretario del consiglio provinciale, ed ogni tanto gli capitava di dover andare nell’isola insieme ad assessori e consiglieri. Il dott. Fattovich in quelle occasioni vi svolgeva il ruolo di anfitrione, a modo suo. Mi raccontò mio padre che una volta, essendo la delegazione provinciale invitata a pranzo, il dott. Fattovich la portò a visitare il gabinetto scientifico, ove si profuse in spiegazioni sui numerosi cervelli “anomali” conservati in formalina. Quando si assisero a tavola, la prima pietanza che fu servita agli ospiti perplessi, mentre Fattovich si sganasciava, furono cervella fritte. Un episodio altamente simbolico.
In realtà questo libro, A sé e agli altri, non è propriamente un libro sull’autismo misconosciuto, e nemmeno sulle disabilità relazionali fraintese e interpretate nei modi più diversi, con una sorta di frenesia nomenclatoria, sebbene l’autismo compaia in più luoghi e in più saggi. È un libro sulla psichiatria, sul suo complesso di inferiorità nei confronti degli altri saperi medici, sul suo procedere a tentoni, sul suo frequente adagiarsi nell’inerzia dei luoghi comuni socialmente condivisi e delle ideologie dominanti, sul suo sostanziale fallimento che ha seminato incommensurabili sofferenze. Questo fallimento traspare anche dal moltiplicarsi dei nomi assegnati alle malattie mentali, che si avvicendano in un rampollare inesauribile. Scrive Pietro Barbetta a p. 175 : «… il caos dell’inconscio psichiatrico può essere colto attraverso l’analisi dei significanti diagnostici. Immaginate una grande discarica, ove sono depositate tutte le parole che il discorso psichiatrico ha abbandonato. Ci avviciniamo alla discarica e troviamo parole che spuntano, riemergono secondo come muoviamo i rifiuti per cercare–come homeless, bricoleur, come cani randagi o ratti–qualcosa d’interessante. Ecco che spunta una parola, è già in superficie: oligofrenia. Attaccati per l’asse sintagmatico al suffisso si trovano frenastenia, frenopatia, schizofrenia, ebefrenia, frenetico, frenologia, freniatria, ecc., per l’asse paradigmatico: debolezza mentale, insufficienza, ritardo intellettivo, deficit, quoziente intellettivo, malformazione cognitiva, ecc.» (p. 175)
E l’autismo? Nell’insieme, questo libro è ostile ad ogni riduzionismo neuroscientifico e neurocognitivo, e in più modi sembra mettere in questione la stessa categoria diagnostica, oggi dilagante, di autismo. La sua impostazione fondamentalmente umanistica, che io apprezzo, mi sembra però sostanzialmente rifuggire da un vero confronto con le neuroscienze, confronto sul quale oggi si gioca tutto. Anche se è vero che il proprium del libro è l’intento di far risaltare la storia di San Servolo attraverso alcune vicende umane che lo hanno attraversato, è pur vero che quelle storie sono presentate come esemplari e su di esse ed intorno ad esse si articola una pluralità di discorsi che investono l’oggi della psichiatria. Vediamo solo qualche punto che potrebbe sollecitare l’interesse e la riflessione di chi di autismo si occupa, genitori compresi .
«Il proliferare delle diagnosi ha spinto a parlare di un’ “epidemia” di autismo mentre, come evidenziato da Roy Grinker (Grinker, 2007), Ian Hacking (Hacking, 2008) e Gil Eyal (Eyal & al., 2010), l’epidemia è di carattere culturale: è aumentata l’attenzione per la dimensione relazionale dell’esistenza, conseguentemente per le sue forme atipiche e patologiche. (…) Oggi la dimensione cognitiva è considerata un correlato dipendente dall’attitudine relazionale, il ritardo mentale è stato sussunto dall’autismo (gli allarmisti che invocano fondi per la ricerca sull’autismo a fronte dell’epidemia, non considerano come contestualmente sia venuto meno un numero corrispondente di persone diagnosticate per ritardo mentale).» (E. Valtellina, p. 8)
«… autismo non è un’entità clinica, una patologia individuabile per un’eziologia, ma il contenitore lessicale che raccoglie condizioni disparate, riunite per la comune manifestazione di forme atipiche dell’interazione in presenza.» (Valtellina, p. 9)
Non tutti i saggi del libro mi appaiono compiutamente perspicui. Alcuni, forse per le dimensioni ridotte in cui sono costretti, pongono qualche interrogativo sulla linea di pensiero che li fonda e percorre. Ad esempio quello, molto stimolante, di Andrèe Bella, Follia morale e modernità: la socializzazione impossibile, inizia citando Figure dell’autismo. Delle rappresentazioni in piena evoluzione di Ian Hacking, sostenendo che «parlando di autismo non ci troveremmo di fronte ad un continuum lineare unidimensionale, entro cui ci si può situare a fronte della maggiore o minore gravità dei sintomi, come suggerirebbe la metafora dello spettro, bensì di fronte ad uno spazio che può contenere e descrivere vari tipi di qualità, dimensioni e figure diverse che si interfacciano in modo complesso e multisfaccettato tra loro». E questa è oggi una questione fondamentale. E tuttavia, dopo un’apertura sull’autismo, Bella si sofferma sui casi, descritti nelle cartelle di S. Servolo, del sacerdote Giovanni Rampin (1818-1884) e dell’avventuriero professore di lingue Samuele Mendel(1831-1908). La follia morale (una diagnosi frequente ai loro tempi) di questi due interessanti personaggi non ha nulla a che fare con l’autismo, ma pone la stessa questione, quella delle tecniche di produzione della verità (p. 110). In effetti, vista la dimensione storica di transitorietà e di costruzione sociale di molte patologie psichiatriche c’è da chiedersi se tra cinquant’anni si parlerà ancora di autismo e di spettro autistico o se saranno sopravvenute nuove definizioni, nuove etichette e nuovi cataloghi. Secondo Bella «…l’autismo e la follia morale, in quanto disabilità relazionali, presentano le medesime questioni metafisiche ed epistemologiche in forme e realtà storiche molto diverse». (p.111)
Infine, mi sembra di dover richiamare quella che anche oggi è una prospettiva che, mutatis mutandis, incombe sulle famiglie: «L’assistenza familiare ai malati di mente venne sostenuta durante l’inchiesta sui manicomi italiani, condotta da Cesare Lombroso e Augusto Tamburini nel 1891 in vista di una futura riforma volta a far fronte allo stato di sostanziale degrado in cui versavano i manicomi italiani. [...] Tra le problematiche ravvisate dall’inchiesta vi era quella dell’accumulo enorme e sempre crescente di pazzi; tra questi, quelli buoni, tranquilli e idioti, si sarebbero potuti collocare–secondo Lombroso e Tamburini–presso la propria o l’altrui famiglia dietro elargizione di sussidi.» (B. Catini, p. 53, nota 13).


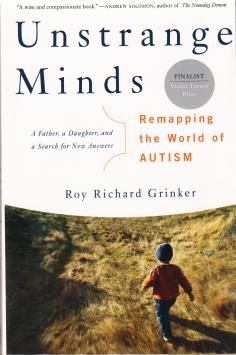
Roy Richard Grinker, figlio e nipote di psichiatri e psicoanalisti, e marito di una psichiatra, è un antropologo culturale, direttore dell’Institute for Ethnographic Research della George Washington University. Ed è anche il padre di Isabel, una ragazza autistica. Il suo libro Unstrange Minds (Basic Books 2007) è certamente uno dei più belli che io abbia letto sull’argomento autismo. È una storia familiare, una delle tante che ruotano intorno ad un figlio o ad una figlia con autismo, ma è anche una ricerca, ampia e interessante. Poiché Grinker è un antropologo, non può non osservare l’autismo anche come fenomeno culturale. Così egli si muove dall’Africa tribale all’India e alla Corea, scoprendo come il fenomeno dell’autismo si declini nei modi tipici di ogni società, e come l’aspetto culturale determini in modo impressionate non solo la condizione di vita delle famiglie delle persone con autismo, ma la realtà dell’autismo stesso. Non è assolutamente la stessa cosa essere autistici in un villaggio Zulu o a Città del Capo, in un villaggio nella giungla indiana o nella metropoli di Delhi, nelle colline della Corea o a Seoul: in genere la condizione di vita per gli autistici è migliore nelle zone rurali, fatta salva la pesante influenza della medicina e della magia tradizionali. Unstrange Minds è un testo che discende da una mente aperta, e chiede apertura mentale–una merce rara ovunque, e anche tra coloro che si occupano di autismo.
Grinker fornisce fin dall’inizio al lettore alcuni punti fermi. «Non si può osservare l’autismo sotto un microscopio o scoprirlo con un test di laboratorio. L’unica evidenza che abbiamo dell’autismo di qualcuno è il suo comportamento individuale. Vi è scarso accordo, perfino dentro una singola cultura, circa che cosa sia esattamente o come lo si debba trattare. Così, quando iniziamo ad andare in panico per l’aumento nella prevalenza di certe condizioni o disturbi è bene ricordare che la maggior parte delle diagnosi psichiatriche sono essenzialmente soltanto descrizioni e classificazioni basate sui comportamenti che determinati clinici hanno osservato e scelto di enfatizzare in un particolare punto nel tempo, ed essi possono anche riflettere i condizionamenti personali e culturali dei singoli clinici. La descrizione di un certo paziente da parte di un clinico, e di qui la diagnosi assegnata a quel paziente, può variare considerevolmente dalla descrizione dello stesso caso fornita da un altro clinico, anche quando entrambi i clinici appartengano alla medesima cultura. Variazioni molto più ampie nelle diagnosi si osservano nel passaggio tra culture differenti. Molte società, per esempio, non hanno nemmeno una parola per autismo, mentre in altre i sintomi dell’autismo non vengono pensati come anormali, ma piuttosto come divini o spirituali. » (pp. 2-3)
Come spiega a p. 11, Grinker osserva l’autismo come un fenomeno globale, e non soltanto come un disturbo neurobiologico ma come un gruppo di sintomi che sono diventati particolarmente significativi in tempi e luoghi determinati. Nel libro dunque non potevano mancare elementi di storia della sindrome, e vi sono belle pagine sulla vita di Kanner e di Asperger, non prive di umorismo e sottigliezza psicologica. Viene affrontata brillantemente la questione della supposta epidemia di autismo, giustamente posta in relazione al crollo delle diagnosi di ritardo mentale e alle modalità in cui, anzitutto negli USA, sono gestiti gli interventi assistenziali dei singoli Stati. Una ricerca storica in questo campo, unita ad una razionalizzazione nell’uso delle categorie di prevalenza e incidenza, mostra secondo Grinker come non vi siano i dati per parlare di epidemia di autismo: sono le categorie psichiatriche che si muovono, e il caso dell’isteria, un tempo male comune delle donne occidentali e oggi sparita come categoria diagnostica, dovrebbe rendercene edotti. L’autismo è una epidemia culturale. Rimangono forti pulsioni di massa, anche tra i genitori, e sono ben spiegabili: «Non so con certezza perché la gente resista tanto all’idea che l’autismo autentico possa essere rimasto numericamente stabile nel corso degli anni, e che non esista una reale epidemia. Forse la gente non vuole abbandonare la speranza che, se soltanto potessimo trovare la causa dell’”epidemia”, allora potremmo aiutare questi bambini. Potremmo eliminare le tossine, controllare e rendere affidabili le multinazionali, fare qualcosa per invertire la tendenza. Se non vi è alcuna reale epidemia, allora dovremmo ammettere che non vi è alcuno su cui riversare la colpa. Il desiderio della gente è comprensibile. Ma noi non possiamo trovare soluzioni reali se basiamo le nostre idee su false premesse e cattiva scienza» (p.172). Siamo perfettamente d’accordo: è la logica del capro espiatorio, cui sempre gli umani in difficoltà fanno ricorso. Ma il libro è ricchissimo di argomenti e personaggi, da leggere assolutamente.






The Autism Matrix, di Gil Eyal et al. (Polity Press 2010) reca come sottotitolo The Social Origins of the Autism Epidemic. Ovvero le origini sociali dell’epidemia di autismo, quella che spinge molti a ricercarne le cause più varie, spesso senza alcun serio fondamento scientifico. Se infatti è vero che i numeri delle persone con diagnosi di autismo sono in grande crescita soprattutto nel mondo sviluppato, occorre secondo Eyal chiedersi non tanto perché oggi si facciano queste diagnosi, ma perché fino a pochi anni fa non si facessero. La questione è infatti prima di tutto sociale. Il discorso che il libro svolge è complesso e raffinato, e non cade mai in ingenuità né si fa imbrigliare da tesi precostituite, ma a seguito dell’analisi svolta alcuni elementi ne emergono con chiarezza, e anzitutto questo: non è che negli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta non si facessero diagnosi riguardanti la condizione mentale dei bambini. No, si facevano, e in gran quantità. Solo che semplicemente non erano diagnosi di autismo. L’etichetta diagnostica autismo non era in uso, o il suo uso era limitato, come per differenti motivi vollero gli stessi Kanner e Rimland (ad es. vedi p. 187), a poche situazioni ben definite. Quindi non vi erano soggetti autistici, ma vi erano molti altri malati di mente o ritardati, con variazioni nel tempo che potrebbero configurare diverse altre epidemie, come quelle di deficienza mentale degli anni Quaranta o di schizofrenia infantile negli anni Cinquanta. Nel 1948 negli USA 108.500 bambini mentalmente ritardati erano inseriti nell’educazione speciale. Nel 1966 erano diventati 540.000. Dunque, nel 1966, ripetiamo, 540.000 bambini negli USA venivano seguiti da programmi di educazione speciale in quanto in vario grado ritardati. La cifra è enorme, e interpella seriamente coloro che parlano di “epidemia di autismo in corso”, perché la fluttuazione dei significanti, con lo spostamento diagnostico e l’attribuzione di etichette varianti nel tempo, è un dato storico impressionante.
All’interno del libro di Eyal mi pare di poter individuare due cardini: il primo è la deistituzionalizzazione del ritardo mentale iniziata a metà degli anni Settanta, che ha comportato una immensa dislocazione culturale e pratica, rendendo possibile un nuovo ruolo, protagonistico, delle famiglie e il sorgere di nuove professionalità, alleate con le famiglie, al di fuori della psichiatria tradizionale. Lo svuotamento degli istituti come la prima formidabile scossa di terremoto cui sono seguite innumerevoli scosse di assestamento, fino alla nascita dello spettro autistico come entità onnivora. «L’autismo così è diventato proteiforme, un vasto spettro che ingloba forme multiple e molteplici gradi di severità, un ‘significante fluttuante’ che può essere molte cose contemporaneamente, che può indicare allo stesso tempo una cosa e il suo contrario: ritardo mentale profondo e abilità da quasi-genio, ipersensibilità e iposensibilità, distacco ed eccessivo attaccamento, assenza di emozioni ed esplosioni di ira.» ( pp. 24-25)
Il secondo cardine è il generale offuscamento dei confini: tra malattia mentale e ritardo mentale, tra medicina convenzionale e non-convenzionale, tra professionisti e genitori, ecc. Ma come il processo di istituzionalizzazione–che ha visto innumerevoli bambini rinchiusi tra quattro mura dopo essere stati allontanati dalla famiglia–fu un prodotto storico-culturale ed economico che non può essere pienamente compreso senza uno sguardo vasto (un’ottica puramente tecnico-psichiatrica sarebbe fuorviante), così anche la creazione dello spettro dell’autismo e le sue attuali polimorfiche manifestazioni possono essere davvero colte solo allargando la visione, e seguendo la via tracciata da Eyal in questo splendido libro, che dovrebbero leggere tutti coloro che discutono di autismo. Noticina finale: Nel 2007 in Inghilterra risultavano ricoverati in istituti 2.245 bambini. In Francia, la patria del lacanismo, 108.000. (p.62) Da noi non saprei dire.